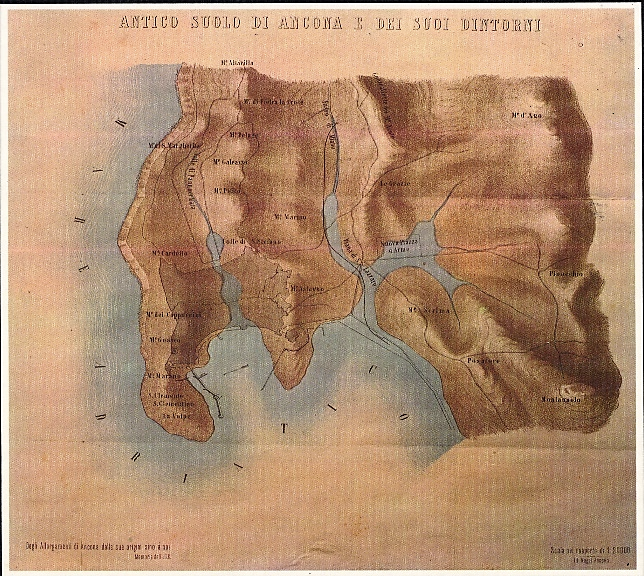
In epoca preistorica il territorio di Ancona era caratterizzato da una
dorsale costiera, formata da marne calcaree, una dorsale collinare parallela,
formata da argilla marnosa, al centro delle quali era una depressione valliva,
chiama anticamente valle della Pennocchiara ove il mare penetrava rendendo il
terreno acquitrinoso con presenza di canneti (l’attuale spina dei corsi).
A sud-ovest, l’insenatura presentava un’altra depressione, anch’essa permeata dalle
acque salmastre (il Piano S. Lazzaro).
La linea della costa ha subito nel tempo un notevole arretramento, dovuto
all’azione eolica e marina, alle infiltrazioni delle acque nonché ai periodici
e talvolta importanti fenomeni tellurici.
Quello qui mostrato in pianta è solamente un tentativo (molto discusso per
la generosità delle proporzioni) d’immaginare l’Antico suolo di Ancona e dei
suoi dintorni che nel 1884 l'ing. Gustavo Bevilacqua propose.
Età del Bronzo
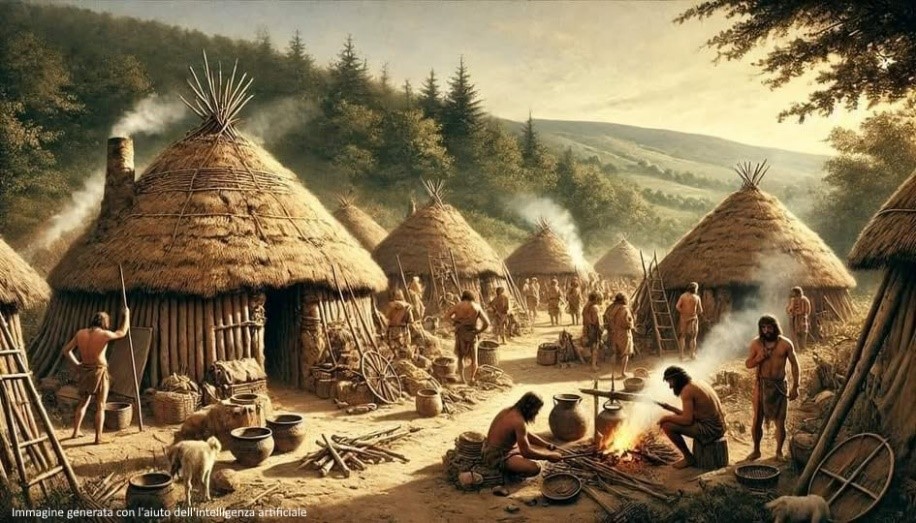
Le prime tracce di insediamenti stabili relative al passaggio dall’Eneolitico
al Bronzo Antico (2200-1600 a.C.) si trovano sul versante occidentale del colle
Cardeto. Successivamente, nel Bronzo Medio (1600-1300 a.C.) e nel Bronzo finale
(1300-1000 a.C.), la presenza umana, attribuita alla gens protovillanoviana, si
espanse gradualmente anche sul colle dei Cappuccini. In questo periodo
l’antropizzazione era costituita da piccoli villaggi indipendenti l’uno dall’altro.
Un altro villaggio, appartenente alla medesima cultura, sorse contemporaneamente
sul colle del Montagnolo.
Età del Ferro

La colonizzazione della dorsale costiera continuò a svilupparsi nell'Età
del Ferro, quando, non appena apparsi, i Piceni divennero rapidamente dominanti e
si attestarono anche sul colle Guasco. Col tempo si assistette ad un’unione
dei villaggi separati in una struttura più omogenea.
Le particolari caratteristiche orografiche della costa, dominate dall’emergenza
del monte Conero, rendevano l’approdo a Numana e ad Ancona molto agevole e
ciò contribuì allo sviluppo di commerci sviluppati dai mercanti micenei alla
ricerca di metalli e dell’ambra. Ancona divenne un emporio greco, anche se a
quel tempo Numana era più importante in quanto primo approdo per le navi che
risalivano la costa adriatica. Le popolazioni convivevano con un lento processo
di assimilazione reciproca.
La colonia Greca

Se all’inizio la provenienza dei mercanti greci era dalla madrepatria, nel IV
secolo a. C. si assiste ad una colonizzazione da parte della Magna Grecia il cui
egemone, Dionisio il Vecchio, tiranno di Siracusa, estese la sua influenza anche
sull’Adriatico. La fondazione della polis anconitana, viste le fonti storiche,
viene fissata nel 387 a. C. quando un gruppo di esuli provenienti da Siracusa si
trasferirono in loco.
Gli storici locali collocano i primi insediamenti greci a volte sul colle S. Stefano,
altre sul Montagnolo oppure nei pressi del porto. Quanto ai siracusani si parla di
un loro primo stanziamento sul colle Astagno. Tuttavia non sono stati rinvenuti
reperti archeologici che possano comprovare alcuna delle tesi precedenti.
I nuovi arrivati, in ogni caso, assorbirono pacificamente la popolazione autoctona
e strutturarono razionalmente la città. Sul colle Guasco sorse l’acropoli (ove si
ergeva un santuario dedicato ad Artemide) con attorno l’area sacra delimitata da mura;
in una zona intermedia era posizionata l’agorà mentre più in basso, verso il porto,
si trovavano per lo più le abitazioni e le attività artigianali. Di questa struttura
urbanistica, escluso il tempio, pochissimo è rimasto di sicura attribuzione.
Per un approfondimento si rimanda alle cartine tematiche.
Il Municipio Romano

La città ebbe un periodo fiorente durante la fase ellenistica che
gradualmente venne sostituita da quella romana. L’avvento dei Romani
nelle Marche, dopo tentativi di ribellione da parte delle popolazioni
autoctone, portò Ancona a diventare in un primo momento una città ''foederata''
e successivamente, tra il 90 e l’88 a.C., un ''municipium''. Nel porto si istallò
la flotta romana e alla popolazione di origine picena e greca si unì quella
proveniente da Roma. Ancona, pur formalmente romana restò a lungo una città
volta ad oriente di cultura prevalentemente ellenistica, tanto che i cittadini
romani ivi insediati sembrano aver anch’essi assorbito usi e formalità di
ispirazione grecizzante.
Se i Dori avevano imposto la loro urbanistica, i romani espansero e
razionalizzarono l’abitato ampliando le strutture pubbliche. Notevoli i
rimaneggiamenti del tempio, ora dedicato a Venere, l’erezione, in epoca
repubblicana, dell’Anfiteatro e la realizzazione del Foro.
Massima espansione romana

Comprendendo l'importanza strategica e commerciale che aveva la città, l'imperatore
Traiano procedette ad un suo notevole miglioramento, fortificandola e dotandola di un porto
più ampio e funzionale. Per ricordare ciò il Senato e il popolo romano dedicarono
all'imperatore l'Arco di Traiano, ancora oggi uno dei simboli della città, ammirabile
nell'area portuale.
Da questo porto Traiano, secondo interpretazioni non unanimi di una scena della Colonna Traiana,
si sarebbe imbarcato con le sue truppe nel 105 d. C., per intraprendere la seconda guerra
dacica. I Romani consideravano Ancona l'accesso d'Italia da Oriente e quindi la sede naturale
dei commerci con la Dalmazia, l'Egitto e l'Asia.
Secoli bui e medioevo

A seguito dei rivolgimenti causati dalle invasioni barbariche e dalla caduta
dell’Impero Romano d’Occidente nel 476, Ancona visse un periodo buio nel quale
anche i confini della città gradualmente si restrinsero fino a limitarsi quasi
solo al colle Guasco fortificato. Oltre alle distruzioni e alle razzie belliche
il luogo venne trasformato da un pauroso evento sismico avvenuto nel 558 d. C. che
fece franare in mare una parte del colle Guasco, un ragguardevole tratto della
dorsale costiera e che comportò la completa distruzione della città di Numana.
Inoltre, nell’ 848 d. C., la città divenne preda dei pirati Saraceni che la
razziarono e la rasero praticamente al suolo, distruggendo il porto romano.
Tuttavia nel corso degli anni Ancona seppe risollevarsi e a partire alle soglie
del X secolo inizia un cammino verso l'indipendenza, favorito dall'aumento dei commerci.
Alla fine dell'XII secolo Ancona, pur sottomessa alla Chiesa, ebbe un'indipendenza de
facto: il papa Alessandro III (circa 1100-1181) la dichiarò città libera nell'ambito
dello Stato della Chiesa. Memore dei pericoli corsi in precedenza la città venne
cinta da una cortina di mura che consentì di resistere agli assedi dell'imperatore
Lotario II, nel 1137, e di Federico Barbarossa nel 1167 e nel 1173.
Ancona era una città dedita soprattutto al commercio, tramite dei traffici con
l’Oriente e con il Nord Europa. Vessata dalla preponderante concorrenza di Venezia,
seppe trovare una sua propria collocazione, anche attraverso la stretta alleanza
con Ragusa (Dubrovnik) e gli stretti legami con l’Impero d’Oriente.
L'epoca d'oro repubblicana
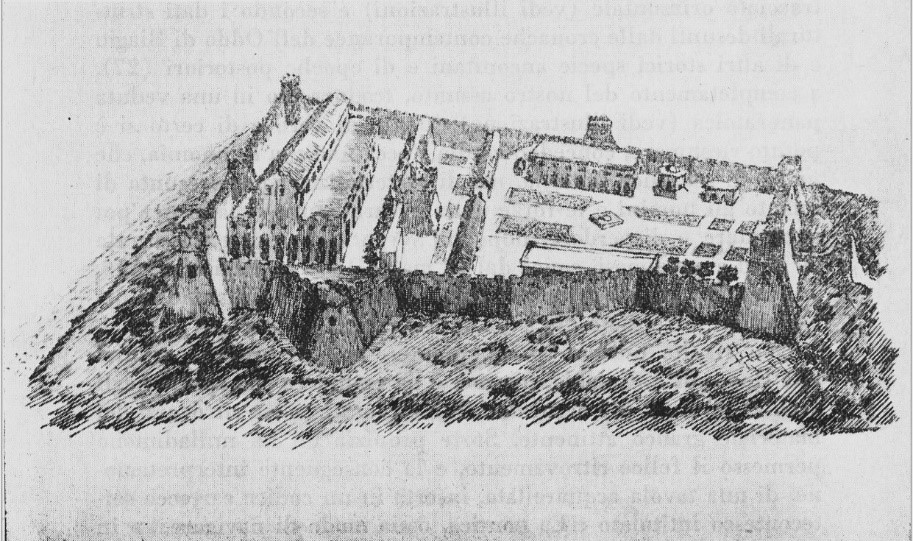
Quando Papa Eugenio IV confermò la posizione giuridica della città
definita dal suo predecessore dichiarandola ufficialmente repubblica
il 2 settembre 1443, Ancona poteva contare su floridi commerci e ampi
rapporti internazionali che si tradussero in un benessere economico.
Nel 1329 si poté procedere all’ampliamento delle mura castellane fino
a porta Farina e porta Calamo e da Capodimonte a S. Agostino.
Nel 1348 il Cardinale Albornoz fece costruire sul colle dei Cappuccini
la Rocca di S. Cataldo come residenza estiva del Papa che verrà distrutta
nel 1383 dagli anconitani onde evitare dominazioni, vessazioni e tasse
oppressive da parte di estranei.
Fine dell’autonomia
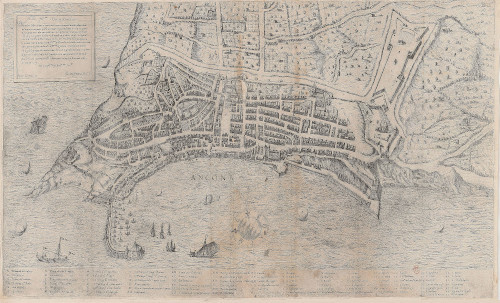
La libera amministrazione di cui il comune aveva beneficiato giunse
improvvisamente (ignorati gli allarmi da parte degli alleati, come Ascoli)
al termine. All’inizio di questo secolo vennero ulteriormente espanse
le mura urbiche sul crinale scosceso di Capodimonte ma soprattutto il
papa Clemente VI si offrì di fortificare ulteriormente la città erigendo
una nuova rocca. Gli anconitani accettarono questa proposta per proteggersi
da una ventilata minaccia turca (una fola diffusa ad arte) e visto che
le spese erano sostenute dalla Chiesa, senza comprendere che la fortezza
era il controllo papale della città. Nel 1532, col completamento (parziale)
della Fortezza, sulla sommità del colle Astagno, il delegato pontificio
Bernardino Castellari, detto Della Barba, del Monferrato, prese possesso
per conto del papa della città che, con l’insediamento del Cardinale
Benedetto Accolti, aretino, cardinale di Ravenna, perse così la sua autonomia.
Il cardinale aveva letteralmente acquistato Ancona dal papa per un canone
di 20.000 ducati d’oro annui.
Lo Stato della Chiesa

Sotto la stretta amministrazione papale Ancona visse alterne vicende
sociali ed economiche. Nel Seicento le dimensioni della città rimasero
sostanzialmente invariate; nel 1690 si verificò un fortissimo terremoto
che provocò ingenti danni cui seguì un periodo di profonda crisi economica
e demografica.
Solo negli anni 30 del Settecento Ancona poté risollevarsi grazie alla
concessione del porto franco da parte del pontefice Clemente XII
che commissionò importanti lavori di sistemazione del porto e l’edificazione
del grande Lazzaretto affidata all’architetto Luigi Vanvitelli.
Lo Stato Unitario
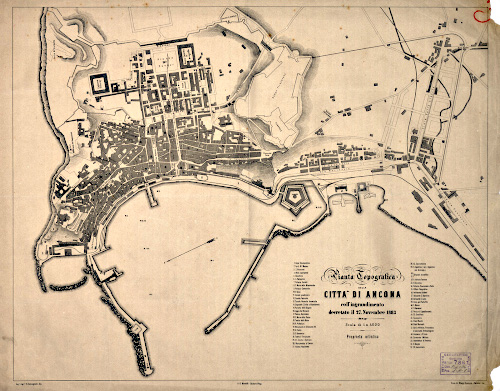
Un nuovo e consistente sviluppo della città si verificò all’indomani
dell’unificazione italiana. Il governo sabaudo dichiarò Ancona piazzaforte
di prima categoria e ampliò le fortificazioni espandendole dal colle Cardeto
al colle del Pincio, discendendo poi, con la cinta daziaria fino al Piano
San Lazzaro.
Il centro verrà rivoluzionato secondo gli stilemi dell’architettura
post-unitaria, con la creazione del corso principale (oggi corso Garibaldi),
della piazza Cavour, del teatro delle Muse, della stazione ferroviaria e
con numerosi altri interventi urbanistici.
A cavallo tra le due guerre

In questo periodo, mutate le tecniche militari e le necessità difensive,
si aprì per l’abitato la possibilità di dilagare oltre le mura, soprattutto
nella parte est della vallata centrale, quella che era chiamata la valle
degli Orti.
Siamo già nella fase più moderna dell’espansione edilizia che, dopo un
drammatico arresto causato dalle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale,
riprese con maggior e inarrestato vigore sino alla situazione attuale
(visibile nello sfondo grigio sottostante a tutte le piante, come base
di riferimento).